SONO I PIÙ BUONI AL MONDO E NATURALMENTE, NON SONO IO A DIRLO: LE ESPORTAZIONI CRESCONO A LIVELLO ESPONENZIALE E IL CONSUMO È SEMPRE MAGGIORE; I RICONOSCIMENTI E PREMI, ORMAI NON FANNO PIÙ NOTIZIA.
NON PERDETE QUINDI L'OCCASIONE DI ASSAGGIARE QUESTE PRELIBATEZZE DELIZIOSE, NEL VOSTRO PROSSIMO VIAGGIO IN ITALIA.
SE, COME ABBIAMO GIÀ DETTO PER I VINI, I PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI POSSONO ECCELLERE NEL MONDO INTERO, È ANCHE GRAZIE PROPRIO AI FORMAGGI NOSTRANI. NATURALMENTE DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI, SOPRATTUTTO QUELLE FRANCESI (...).
I formaggi
italiani
L’Italia vanta un notevole
patrimonio caseario: sono 403 i formaggi prodotti, di cui circa una
cinquantina tutelati dalla denominazione di origine protetta (Dop). Ce ne sono
di famosi nel mondo come Mozzarella e Parmigiano Reggiano, e di tremendamente
locali, come il Formai de mut, formaggio di monte della Alta Val Brembana
(Bergamo), il Silter, una sorta di casera bresciana o la Vastedda del Belice
(Sicilia), l'unico formaggio a pasta filata prodotto con latte ovino.
Ed è il Nord a vantare il maggior numero di Dop: Lombardia, Veneto e Piemonte sono le regioni che ne contano di più. La prima ha circa una decina di formaggi tutelati, dai più celebri, Gorgonzola, Grana padano e Taleggio ai più locali come la Formaggella del Luinese un formaggio di capra prodotto nelle valli intorno al lago Maggiore (Varese) o il Quartirolo lombardo uno stracchino quadrato che ha addirittura origini medioevali.
In Piemonte c'è invece la provincia con più formaggi Dop d'Italia: Cuneo, che ha l'esclusiva su Castelmagno, Raschera e Murazzano e condivide con altre le denominazioni di Grana padano, Gorgonzola, Bra e Toma piemontese.
Ma anche il centro e il Sud d'Italia sono ricchi di formaggi tipici e apprezzati: basti citare i vari pecorini dal toscano al romano, passando dal sardo al siciliano e a quello di Filiano (Basilicata) oppure al Provolone o alla Mozzarella di Bufala campana, esportati in tutto il mondo. Gli ultimi formaggi ammessi nel registro Dop sono lo Squacquerone (Emilia Romagna) e lo Strachitunt (Lombardia) che hanno ricevuto il marchio nel 2012.
A dispetto dei nostri storici concorrenti d'Oltralpe, i formaggi italiani, nel 2011, hanno superato i formaggi francesi anche in Francia, e sono da anni i prodotti alimentari più imitati e contraffatti al mondo. I primi mercati di sbocco dell'export, secondo i dati di Assolatte, sono Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito per un giro d'affari di quasi due miliardi di euro. E' il Grana Padano il prodotto Dop più venduto all'estero. Insomma, in tema di formaggi, il campanilismo per ora ha dato buoni frutti.
SUDDIVISIONE
Di primo acchito volevo suddividerli per regione di
produzione. Considerato, però, che alcuni formaggi vengono prodotti in più
regioni, per comodità ho pensato alla soluzione più semplice, cioè elencarli in
ordine alfabetico.
Non per essere nazionalista, ma personalmente trovo
che i formaggi italiani siano tra i più buoni del mondo (non me ne vogliano i
francesi...)
Comincerò col dirvi che la loro classificazione in
categorie avviene a seconda del contenuto di grassi, della consistenza, del
periodo di stagionatura e della temperatura di lavorazione della cagliata.
A seconda della CONSISTENZA,
strettamente legata al contenuto d’acqua, troviamo:
- Formaggi a dura (contenuto d’acqua inferiore al 40%)
- Formaggi a pasta semidura (contenuto d’acqua tra il 40 ed il 45%)
- Formaggi a pasta molle (contenuto d’acqua superiore al 45%)
In base al CONTENUTO DI GRASSO,
troviamo:
- Formaggi magri (contenuto di grassi inferiore al 20% della sostanza
secca, cioè ciò che resta dopo aver tolto l’acqua), preparati con latte
scremato.
- Formaggi leggeri (contenuto di grassi tra il 20 ed il 35% della
sostanza secca)
- Formaggi preparati con latte intero (contenuto di grasso superiore
al 35% della sostenza secca).
Se vogliamo suddividerli in base alla TEMPERATURA
DI LAVORAZIONE DELLA CAGLIATA, abbiamo:
- Formaggi a pasta filata: gruppo a sé stante, caratterizzati dalla
filatura della cagliata in acqua calda
- Formaggi a pasta cotta: si ottengono riscaldando la cagliata oltre
i 48°C
- Formaggi a pasta semicotta: la cagliata riscaldata non supera i
48°C
- Formaggi a pasta cruda: la cagliata non subisce riscaldamento
alcuno.
Suddividendoli, invece, per STAGIONATURA,
saranno suddivisi in 4 gruppi:
- Formaggi stagionati a maturazione lenta: oltre i 6 mesi di
stagionatura
- Formaggi stagionati a maturazione media: stagionatura non superiore
ai 6 mesi
- Formaggi stagionati a maturazione breve: stagionatura che non
supera il mese
- Formaggi freschi: quando vengono consumati entro pochi giorni dalla
loro produzione
Un capitolo a parte meritano i formaggi cosiddetti ERBORINATI,
contraddistinti dalla presenza della muffa "Penicillum glaucum" che
produce macchie verdi nella pasta durante la maturazione. Originari quasi tutti
dalla Lombardia, citiamo i più noti: Gorgonzola, Castelmagno, Murianego.
Ed eccoci alla presentazione di alcuni formaggi:
AOSTINO | ASIAGO | ASIO | BACCELLONE | BAGOSS | BALON | BEL PAESE (ITALICO) | BITTO | BOCCONCINI | BOSCAIOLA | BRA | BRANZI | BRUS | BURRATA | BURRATA DELLE MURGE | BURRINO | CACIO DI LUCARDO | CACIO SARDO |CACIOCAVALLO | CACIOCAVALLO SILANO | CACIOFIORE | CACIOTTA DI URBINO | CACIOTTA MARCHIGIANA | CACIOTTA ROMANA | CACIOTTA TOSCANA | CACIOTTA UMBRA | CAGLIATA | CANESTRATO | CANESTRATO PUGLIESE | CAPRINO | CASATELLA | CASCIOTTA DI URBINO | CASERA |
CASOLET | CASTELMAGNO | CASU MARZU | COTTAGE | CRESCENZA | FIORDILATTE | FIORE
SARDO | FONTAL | FONTINA | FORMAGGELLA | FORMAGGETTA | FORMAGGIO DELLA VAL
FORMAZZA | FORMAGGIO DI FOSSA | FORMAGGIO DI SENIGALLIA | FORMAI DE MUT |FRESA
| GIODDU | GIUNCATA | GORGONZOLA |GRANA PADANO | ITALICO | LATTERIA | MAGRO DI
LATTERIA | MARCETTO | MARZOLINO | MASCARPONE | MONTASIO | MONTE VERONESE |
MORLACCO DEL GRAPPA | MOZZARELLA DI BUFALA | MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA |
MOZZARELLA DI VACCA | MURAZZANO | OVOLINA | PANERONE | PARMIGIANO REGGIANO |
PECORINO | PECORINO CROTONESE | PECORINO ROMANO | PECORINO SARDO | PECORINO
SICILIANO | PECORINO TOSCANO | PESTOLATO DELLA VAL LAGARINA | PIAVE | PRESSATO
| PROVATURA | PROVOLA | PROVOLONE | PROVOLONE VALPADANA | QUARK | QUARTIROLO |
RAGUSANO | | RASCHERA | RASCHIO | RICOTTA | RASPADURA | RAVIGGIOLO |
ROBIOLA | ROBIOLA DI ROCCA VERANO | SA CASADA | SALIGNON | SBRINZ | SCAMORZA |
SIGHER | SILTER | SORA | SQUAQUARON | STERZINGER | STRACCHINO | STRACON |
TALEGGIO | TOMA | TOMINO | VEZZENA | VIVARO
Vi lascio ora a un paio di video molto interessanti...
1) LA DEGUSTAZIONE - video:
http://www.youtube.com/watch?v=sxjqict_jsY&feature=share&list=PL362D6F1AEDDB21BA
2) I formaggi, varietà di sapori - Cenni storici, video:
http://youtu.be/lSRhgWtegbE






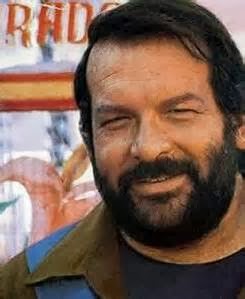
.jpg)